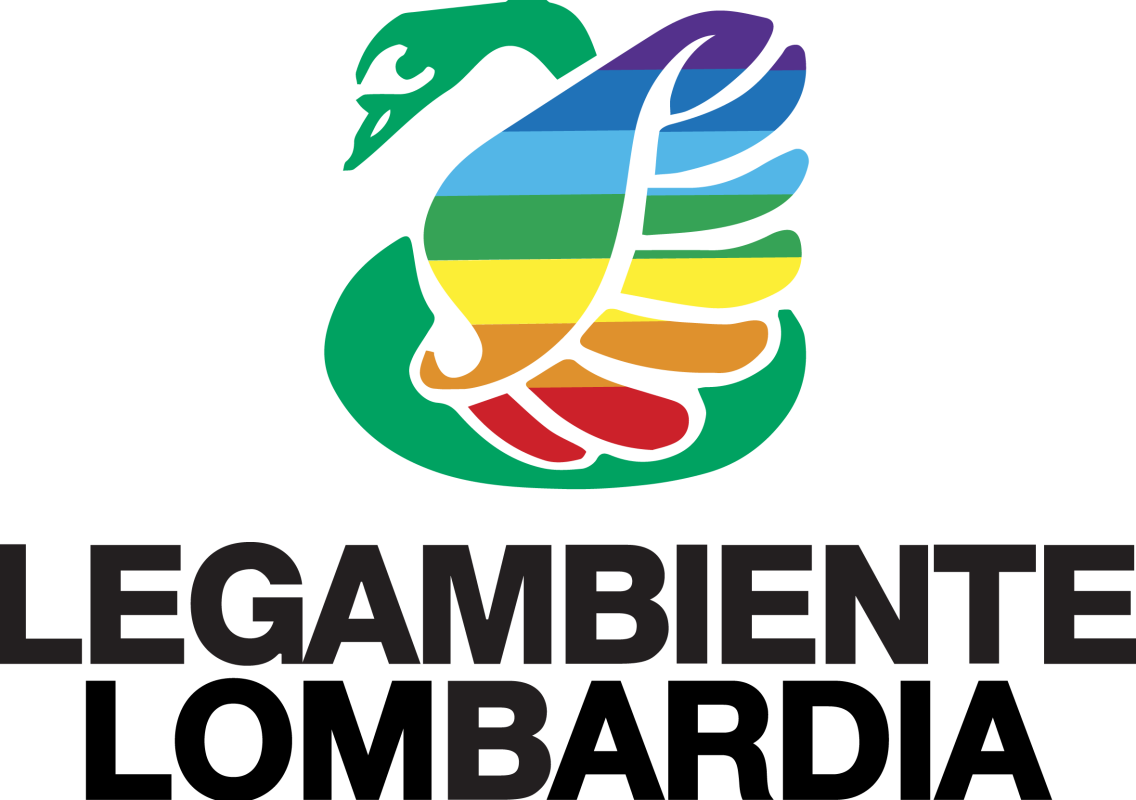Scarica i dati e le infografiche sulla zootecnia intensiva nel Nord Italia

di Damiano di Simine*
Il recente ritorno in grande stile, dopo decenni, delle mucillagini lungo litorali e fondali dell’Adriatico riaccende i riflettori sulla vulnerabilità del mare. La sua scarsa profondità, unita al crescente riscaldamento delle acque, lo rendono estremamente sensibile sia agli effetti del cambiamento climatico sia agli impatti diretti delle attività umane delle coste e dell’entroterra.
Tanto più che è proprio l’Adriatico a essere il recettore delle acque che drenano il grande bacino padano-veneto, con i suoi oltre venti milioni di abitanti, la sua industria e la sua agricoltura intensiva. La formazione di mucillagini in mare è un fenomeno naturale, che in particolari condizioni può diventare visibile a occhio nudo: si tratta infatti della secrezione di microalghe che normalmente vivono in ambiente marino.
I nutrienti non sono quindi la causa diretta della formazione delle mucillagini, ma alimentano le microalghe che le producono. Quest’anno le forti piogge che hanno interessato tutto il bacino del Po hanno dilavato i terreni agricoli trascinando in Adriatico, attraverso i fiumi, molti più nutrienti rispetto alle precedenti annate siccitose.
Sebbene i nutrienti minerali, e in particolare fosforo e azoto, siano indispensabili per tutte le forme viventi, quando presenti in eccesso sono all’origine del fenomeno dell’eutrofizzazione: le alghe acquatiche crescono in modo eccessivo, producendo grandi quantità di biomassa che, decomponendosi, consuma l’ossigeno disciolto in acqua, rendendo l’ambiente inospitale per le forme di vita che dipendono dall’ossigeno, a partire da pesci e molluschi.
Molto è stato fatto, negli ultimi decenni, per ridurre i nutrienti che raggiungono il mare attraverso il fiume Po. Dalla progressiva eliminazione dei fosfati nei detersivi, alla realizzazione, ancora non del tutto completata, delle grandi reti di collettamento e depurazione delle acque di scarico, i settori industriale e civile hanno ridotto fortemente l’apporto di sostanze veicolate al mare, per contrastare l’eutrofizzazione.
Ma tutto ciò non basta per guarire l’Adriatico: all’appello mancano infatti i nutrienti di origine agro-zootecnica, i più importanti per quantità. Agricoltura e, soprattutto, allevamento, ai livelli di intensità praticati nel Nord Italia, restano la prima fonte di inquinamento da fosforo e azoto, per l’uso eccessivo di fertilizzanti minerali e le enormi quantità di liquami zootecnici sversate nei campi.
Secondo i più recenti dati pubblicati da ISTAT, le regioni del Nord si intestano un consumo di fertilizzanti pari al 62% del dato nazionale per l’azoto e del 58% per il fosforo. Lombardia ed Emilia-Romagna da sole totalizzano un impiego di 225.000 tonnellate di azoto minerale: significa che per ogni ettaro di superficie coltivata, in queste due regioni si utilizza il triplo di azoto, rispetto alla media delle altre regioni.
Anche per quanto riguarda gli allevamenti intensivi non c’è confronto: la gran parte dell’allevamento intensivo in Italia si concentra nelle regioni del Nord, in stalle che ospitano oltre 4 milioni di bovini (il 67% del dato nazionale) e 8 milioni di suini (il 90% della porcilaia nazionale), determinando una produzione di molte decine di milioni di tonnellate di liquami e letami che, spante nei campi, lentamente rilasciano il loro carico di azoto e fosforo.
Il problema dell’inquinamento da nutrienti è in relazione alla quantità che le colture vegetali sono in grado di assorbire: nel solo bacino idrografico del Po, a fronte di 700.000 tonnellate di azoto complessivamente distribuite nei campi, le piante possono utilizzarne meno della metà. Ne consegue una perdita di azoto di ben 350.000 tonnellate.
Di queste, secondo un recente studio dell’Autorità Distrettuale del Bacino del Po e delle Università di Ferrara, Parma e Torino, 251.000 tonnellate finiscono ogni anno nei fiumi e nelle falde e da qui, presto o tardi, nell’alto Adriatico. Il resto volatilizza, in forma di gas, ammoniaca e protossido d’azoto, che causano inquinamento atmosferico ed effetto serra.
Nel conto entrano poi le altre fonti di azoto prevalentemente da scarichi civili depurati (27.000 tonnellate all’anno). Per quanto riguarda il fosforo, anch’esso deriva prevalentemente da fonte agrozootecnica (73.000 tonnellate/anno), e in minor misura da scarichi civili (2.800 tonnellate annue).
Nel bacino del Po, la maggior parte degli apporti di nutrienti derivano dalla pianura lombarda, in particolare dai bacini di Adda e Oglio, in cui si concentra il nocciolo del sistema zootecnico padano. Agricoltura e zootecnia recapitano nel Po e in Adriatico quasi il 90% di tutti i nutrienti generati nel bacino: per la salute del nostro mare occorre un uso più consapevole dei fertilizzanti, e passi concreti verso la riduzione degli animali allevati, le cui deiezioni zootecniche costituiscono la parte preponderante dei nutrienti in eccesso dalla Lombardia.
La strategia ‘Farm to Fork’ dell’UE fissa al 2030 il duplice obiettivo, per tutti gli Stati membri, di ridurre del 20% il consumo di fertilizzanti e di dimezzare la perdita di nutrienti. È un obiettivo realistico e pertinente, che darebbe un grosso contributo alla salute di fiumi e mari, riducendo i costi per le aziende agricole.
Per quanto riguarda gli allevamenti, invece, la sfida è più impegnativa ma non meno necessaria: occorre ridurre la densità di animali allevati, a partire da quelle province, come Brescia, Mantova, Cremona, Lodi, Reggio Emilia e Modena, in cui il numero di capi eccede fortemente la capacità del territorio.
Ridurre il numero di animali, in particolare bovini e suini nel Nord Italia e soprattutto in Lombardia, è la strada maestra per una agricoltura più sostenibile e meno inquinante. È quanto chiede una proposta di legge recentemente depositata in Parlamento da ventuno parlamentari di diverse forze politiche. Servono coraggio e investimenti per ristrutturare la filiera zootecnica del Nord Italia, puntando sulla qualità delle produzioni invece che sulla quantità, come si è fatto fino ad ora. Fiumi e mari ringrazieranno.
*Responsabile scientifico, Legambiente Lombardia